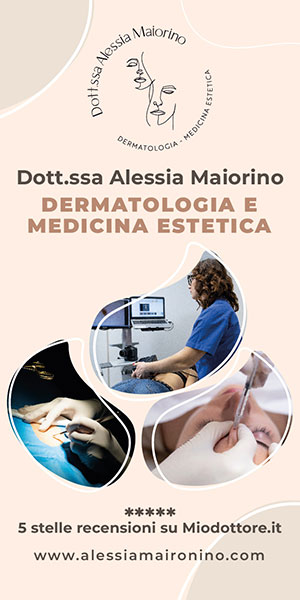Gli anni Settanta erano meglio. E mica solo perché eravamo giovani; sì, vabbè, pure per quello, ma principalmente erano meglio davvero. E anche quello che allora ti faceva incazzare, adesso lo rimpiangi: forse perché allora eri giovane, e non ci pensavi abbastanza. O forse perché adesso sei vecchio, e ci pensi troppo. No, tutto questo non sarebbe mai successo, negli anni Settanta. Certo che no.
CARLO CRESCITELLI bio
Accademicamente connotato da una laurea in Scienze Politiche e da un Dottorato di Ricerca in Filosofia e Teoria Giuridica e Sociale, Carlo Crescitelli ha tuttavia sempre frequentato gli ambiti professionali dell’impresa privata, occupandosi a lungo, tra gli Ottanta e Novanta, di sviluppo risorse umane e di comunicazione aziendale. Ha successivamente condotto, a cavallo dei Duemila, una attività commerciale di promozione e divulgazione di arte etnica, ed è ad oggi attivamente impegnato nell’azione per la salvaguardia del patrimonio tradizionale della provincia in cui vive, l’Irpinia. Da un punto di vista più strettamente culturale, i suoi attuali interessi sono al momento orientati sia all’analisi storica e antropologica, che alla scrittura per il cinema.
Alimentato nel tempo da tutte queste differenti esperienze, il rapporto di Carlo Crescitelli con la scrittura è stato nei decenni costante; meno lo è stato quello con le pubblicazioni. Al suo esordio autoriale del 1990 con il saggio storico-politico La rivoluzione khomeinista iraniana (Nuovo Meridionalismo Edizioni), e in parallelo con il manuale di galateo manageriale per neolaureati Egregio Dottore (Firenze Libri), pubblicato con lo pseudonimo di Massimiliano Conte, è succeduta infatti una lunga, ventennale pausa, terminata soltanto tra il 2010 e il 2011 con la sequenza di quattro uscite per IlMioLibro che comprende i due fortunati diari di viaggio L’antiviaggiatore e Come farai a fuggire da te stesso… se lui continua a correrti dietro?!?, il thriller di fantapolitica The Shadoor, il demenziale vademecum Delinquenti: terapia e prevenzione, pubblicato ancora sotto le spoglie dell’alter ego Massimiliano Conte.
Perfezionato in un ulteriore quinquennio di riflessione e di pubblica pausa, Settanta Revisited esce nella primavera del 2018 e rappresenta la sua nuova riconciliazione con il mondo dell’editoria, determinatasi con l’avvio del rapporto con Il Terebinto Edizioni.
SETTANTA REVISITED: UNA CONVERSAZIONE CON CARLO CRESCITELLI
Difficile parlare degli anni ’70, difficile farlo in un diario, ancor più se semiserio. Allora tocca partire dal centro di tutto: l’autore. Con una domanda difficilissima: come sono stati i tuoi anni ’70?
In effetti per niente facili, come del resto quelli di noi tutti allora… presi com’eravamo dalla ricerca del nostro ruolo in uno scontro epocale che vedeva contrapposto il passato al futuro, una generazione contro l’altra, realtà contro utopia: e dunque anch’io, che come molti già vivevo, pur ancor ragazzino, la potente consapevolezza di essere nel mezzo di un momento importante, avevo il mio da fare per cercare di comprenderlo al meglio. Difficile da spiegare, adesso che ne siamo come lontanissimi, ma la sensazione precisa era proprio questa: sarò all’altezza del mio tempo?
Il racconto degli anni passati, soprattutto se turbolenti come quelli, spesso è fin troppo retorico. Tu hai optato per tutt’altro tipo di “memoriale”, tirando fuori un atteggiamento semiserio e quasi anarcoide…
Ma certo. Come per tutti i contesti di grande tensione emotiva, non può che essere l’ironia a venirti in soccorso: eravamo quelli di “una risata vi seppellirà”, giusto non dimenticarlo mai questo, perché chi fa retorica è sempre lontano dalla verità, e noi di verità ne avevamo fin troppa fame.
Aggettivi ben precisi: “sballata”, “verbosa”, “semiseria”, tu ti definisci “anziano rincattivito”, ma è importante sottolineare che Settanta Revisited è una “guida”. Perché?
Figure tipiche di quegli anni sono state quelle dei “cattivi maestri”, come prima la narrazione di parte avversa, e poi la storia, li hanno connotati e definiti. Ebbene, molto più prosaicamente e con il consueto tocco demenziale che non guasta, io voglio invece oggi pormi quale “maestro cattivo”. Con la mia barba ormai grigia, credo di averne molte buone ragioni.
Avellino anni ’70. Lontano dai centri nevralgici, lontano dalle grandi manifestazioni o dai luoghi del potere “vero”, certe cose arrivavano inevitabilmente in ritardo, e forse proprio per questo gonfiate da un’aura quasi mitica. Quali credi siano state le peculiarità degli anni ’70 avellinesi?
Che fossimo lontani da tutto è verissimo. Nella remota provincia di quasi mezzo secolo fa gli echi sbiaditi e tardivi che ci giungevano dal resto del mondo avevano spesso il sapore della leggenda, del verbo rivelato. E così, qualunque faccenda si ricopriva spesso di una improbabile patina seriosa, quando non tragicomica. Le nostre impacciate schitarrate e stamburate in garage sotto lo sguardo e il giudizio sprezzante dei benpensanti nativi subito pronti a bollarci come “capelloni mezzi drogati” (pur con il paradossale beneficio del dubbio insito nell’uso garantista del termine “mezzi”); la rivoluzione sessuale che noi sapevamo essere in atto altrove, e della quale pur tuttavia accettavamo con serenità la latitanza dalle nostre parti; la buffa commistione di radicate ed amate consuetudini tradizionali locali, gastronomiche e calcistiche, con le allora tanto in voga aspirazioni esterofile e internazionaliste. Tutto come in un vecchio film di Alberto Sordi, insomma, lo diceva anche Nanni Moretti: e se lo diceva lui della capitale, tanto più e a maggior ragione ci vivevamo noi della provincia meridionale, in quel vecchio film di Alberto Sordi.
Inevitabile parlare di musica, mai così identitaria in un periodo come quello. Quanto è stata importante la musica per formare Carlo Crescitelli negli anni di piombo?
Il giovanissimo Carlo Crescitelli conduceva una giocosa rock-jazz band di vocazione dadaista, delle cui movimentiste apparizioni dal vivo era, con la supponenza tipica della verde età, invero assai compiaciuto, salvo poi successivamente nel tempo convenire con i suoi stessi compagni di avventura la poi non grande eccezionalità e splendore di quelle stravaganti performances. Di una cosa però resta convinto: che se le loro ardite partnerships etnicheggianti con i rari africani e southern bluesmen afroamericani disponibili in zona (tutti calamitati dalla locale base militare NATO), o se i loro eccentrici studi di musica popolare berbera fatti su musicassette fortuitamente recuperate avessero avuto luogo appena con qualche anno di ritardo, il riscontro e il successo di tutta l’operazione concettuale, in virtù delle nuove mode ancora di là da venire, sarebbero stati ben diversi. Musica dunque come ennesimo emblema del precorrere i tempi, o per meglio dire del ritrovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ecco, questa è la maggior lezione che si può dire ne abbia tratto.
Anni ’70 senza computer, senza internet, senza informatica, senza colori. Eppure spegnendo la tv in bianco e nero e tuffandosi al Parco Lambro, di colori ce n’erano eccome. Sono solo due delle tante facce di quel decennio…
Grazie di questa domanda: la definizione di anni colorati è più che realistica. Proprio perché, salvo ovviamente che in tv, per il resto i colori erano dappertutto, e senza bisogno neppure di arrivare al Parco Lambro. Forti, vividi e intensi come mai più li ho rivisti: nei vestiti e nei sorrisi di noi giovani, nei sogni d’Oriente che popolavano le nostre fantasie, nell’energia e nella rabbia che tutti, giovani e anziani, buttavano fuori. Con buona pace di Internet, io la sensazione di vivere in un grigio mondo b/n ce l’ho adesso, mica ce l’avevo allora.
Altra domanda pericolosa: un film, un libro, un disco, un luogo che ritieni altamente rappresentativi del clima e dello spirito degli anni ’70.
Il film: La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky. Metafore anticolonialiste, nudità ancestrali, percorsi di ricerca del sé con sberleffo finale. Mirabile sintesi visionaria di tutti i segni del tempo.
Il libro: Il lupo della steppa di Hermann Hesse. Che è un romanzo di fine anni Venti, e apparentemente non c’entra nulla, ma invece c’entra, perché ci spiegava come a un certo punto la realtà può non avere più un solo senso, quando sei tu stesso a diventare, nella tua mutevole molteplicità, il centro della tua stessa realtà. O anche, assai più banalmente se così ti viene il mal di testa a pensarci, perché c’era questa band, gli Steppenwolf, che cantava Born to be wild in sottofondo alle memorabili scarrozzate nel deserto in Easy Rider di Dennis Hopper. Mentre lui, Peter Fonda e poi Jack Nicholson corrono allegri verso il nulla di cui faranno presto le loro vite. Iconico come poco altro.
Il disco. Qui è davvero difficile. Ma scelgo Maledetti degli Area. Con la sue pretenziose, e a tratti manieristiche se non cialtronesche citazioni da Rollerball da un lato, e la purezza esplosiva del genio estemporaneo che lo caratterizza e lo marchia. Tutto è capolavoro in quest’album: dai diforismi urbani in tangente agli smembramenti di quartetti d’archi bachiani, dai perfidi proclami maschicidi ai parimenti cinici e beffardi girotondi da bimbi dannati, al sapore arcaico delle percussioni basche in salsa gerontocratica, alla deliziosamente insulsa e insensata apologia del caos in chiusura. E avremo anche perso la memoria del diciassettesimo secolo, ma una piccola traccia nel ventesimo l’abbiamo lasciata.
Il luogo. Per me è uno della mia adolescenza: le palazzine assegnate a Mercogliano agli ufficiali americani di stanza alla base NATO di Montevergine. Sì, quelli che suonavano con noi per sconfiggere la noia della lunga ferma in Europa e perché eravamo gli unici in città a parlare l’inglese, quelli che ci invitavano a quelle loro feste pazzesche dove l’illusione di essere stati teletrasportati oltreoceano era perfetta, perché ogni dettaglio di cibo e di arredo se l’erano fatto arrivare incredibilmente da casa. Appiccicato sui frigoriferi delle loro cucine, campeggiava spesso per scherzo, ironico e provocatorio, l’adesivo con la figura stilizzata elicoidale e la scritta Caution Radiation Area (manco a farlo apposta proprio quello che appare sulla copertina di un altro album degli Area!), non lasciandoci troppi dubbi sulla reale natura strategica della loro presenza. Né sull’inquietante contenuto che riempiva le cavità della montagna, che anni dopo, appena caduto il Muro a Berlino, sarebbe stata rapidamente svuotata da interminabili carovane di jeep che vedemmo allontanarsi per non tornare mai più. A sottolinearci la fine della guerra fredda che per decenni ci aveva vissuto accanto.
Quel decennio ebbe come protagonisti tanti “compagni che sbagliavano”, anche nella tua Avellino. Al di là del brigatismo e della radicalizzazione dello scontro politico, col senno di poi quali sono stati gli errori principali della tua generazione all’epoca?
Il più grande errore a noi attribuibile si può probabilmente riassumere nel non essere riusciti a prevedere che, per idealisti, pacifisti o brigatisti che avessimo scelto di essere, eravamo comunque destinati alla sconfitta su ogni fronte: le avevamo davvero sottovalutate, le future capacità di reazione del Sistema. Tanto che ancora ci sbeffeggia adesso, riproponendoci la parodia dei nostri desiderata di allora nella recente, strumentale veste del politically correct: vero cuneo di consolidamento dei nuovi, cinici equilibri di oggi, costruiti spesso sulla falsa illusione che le nostre urla di ieri abbiano trovato finalmente ascolto.
Secondo te quegli anni ’70 li abbiamo capiti davvero?
Capiti?!? E cosa c’è da capire?
Tempo fa, la risposta sarebbe stata che l’immaginazione al potere non adotta le categorie borghesi del razionale, proprio come la rivoluzione non è esattamente un pranzo di gala. Ma la verità è che c’è un mondo dentro di noi, un mondo che cresce, e sta crescendo proprio in questo momento in cui sto parlando con te, e se è vero, come è vero, che la parte più ripugnante del tuo corpo è la tua mente, ma chi è allora la polizia del cervello? Fatica sprecata, capire, missione impossibile: assaggiare è quello che serve. Peace & love everybody.